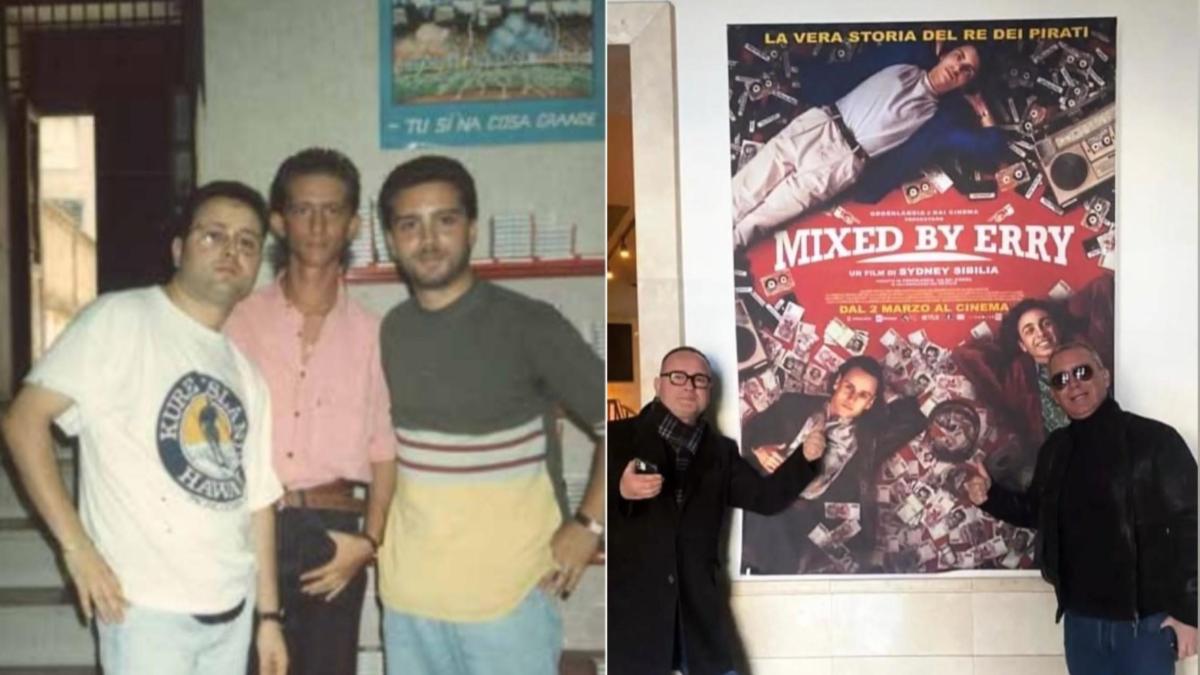Articolo pubblicato il 28 Dicembre 2023 da Christian D’Avanzo
Anno in cui i film d’autore sono stati rilasciati in abbondanza, il 2023 è stato contraddistinto da qualità elevatissima, come già anticipato nella classifica dei migliori, ma non sono mancati i titoli in grado di far discutere il pubblico e i critici tra loro. I grandi ritorni dietro la macchina da presa non sono stati tutti convincenti in egual modo, e c’è chi si è lasciato andare alla provocazione e alla mera ricerca stilistica. In virtù di quanto appena descritto, è bene individuare quelli che sono i peggiori film d’autore del 2023.
Quali sono i peggiori film d’autore del 2023?
Doveroso premettere che la seguente classifica è assolutamente personale, basata sul gusto e le opinioni di chi scrive. Tra gli altri criteri di selezione, c’è la distribuzione: ogni titolo è stato rilasciato ufficialmente in Italia nel 2023, al cinema o su piattaforma. Inoltre, nella “flop” dell’anno vengono contati soprattutto quei film per i quali c’erano grosse aspettative, ma che invece sono risultati piuttosto deludenti, e per varie ragioni. A tal proposito, di seguito si presenta la classifica dei 10 peggiori film d’autore del 2023, ordinati dal decimo al primo posto.
10) L’ordine del tempo, di Liliana Cavani
L’ordine del tempo è stato presentato Fuori Concorso alla 80esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in concomitanza con la sua distribuzione in sala. Cast di volti noti agli italiani, la Cavani si dimostra priva di idee e di creatività, pur lasciando percepire allo spettatore il suo desiderio di condividere la paura della morte. Il pianeta potrebbe essere distrutto, e i protagonisti sono riusciti in una casa al mare durante il periodo estivo; in quel momento, vengono presentate le varie situazioni legate ai rapporti interpersonali.
Tra la recitazione impacciata, i dialoghi surreali e i risvolti di trama quasi del tutto assenti (e quando ci sono, sono altamente telefonati), le quasi due ore del lungometraggio vengono percepite come se fossero il doppio, a dimostrazione di un’assoluta mancanza di ritmo. La riflessione sulla società contemporanea è molto superficiale, quasi irrilevante, e non v’è tracciata di una reale o ipotetica reazione umana di fronte alla possibilità che il mondo finisca. Ogni tentativo di approfondimento finisce per essere una lungaggine, rendendo la visione estenuante.
9) Beau ha paura, di Ari Aster
Nel tentativo di restituire allo spettatore un suo trauma giovanile in chiave cinematografica, Ari Aster si inceppa nella sua stessa libertà creativa, ottenuta tramite la A24 e in seguito ai precedenti successi. Vestendosi di uno spirito fintamente e inutilmente intellettuale, Beau ha paura perde lo smalto dopo appena 30 minuti, il che è un problema non da poco data la corposa durata (3 ore).
Rifugiandosi nelle faccette di Joaquin Phoenix e in una narrazione quasi totalmente onirica, scopiazzando qualche idea dal cinema di Kaufmann e di Lynch, l’astrazione si fa così abbondante da non permettere allo spettatore di seguire un reale filo conduttore. Nel complesso, Beau ha paura è un film d’autore mal concepito, che induce i cinefili a indovinare la citazione e a collegare i puntini rilasciati nell’arco del (non)racconto, invogliando (davvero?) a rivedere il prodotto più e più volte per cercare di venirne a capo.
8) Napoleon, di Ridley Scott
Le intenzioni non fanno il film, verrebbe da dire. Dopo un intelligentissimo e fin troppo sottovalutato House Of Gucci, Ridley Scott realizza un’opera ricca di inutili virtuosismi in battaglia, e contraddistinta da una regia “televisiva” quando si tratta della vita privata dell’icona Napoleone. La sovversione e la caduta di un’icona non bastano a reggere le ridondanti 2 ore e 40 di un lungometraggio in cui il tono e la direzione artistica sono poco chiare: vuole essere una parodia o un film storico? Da un lato ci sono scene volutamente demenziali, anche se ripetute troppe volte perdendo di brillantezza, e dell’altro ci sono ambizioni pedagogiche sottolineate dall’inserimento del testo in sovrimpressione.
Non si capisce, dunque, se Napoleon è una commedia o un film storico che ricostruisce le fasi salienti della vita di un personaggio conosciuto in tutto il mondo. Delle volte il tono è serioso, delle volte ci sono elementi ridicolizzanti, poi arriva la spettacolare battaglia di turno dove le sequenze d’azione mancano di enfasi. Insomma, l’ultimo film di Ridley Scott è piuttosto confuso, ma soprattutto ripete il medesimo schema per 2 ore e 40, proponendo in certe occasioni degli sfondi ottimi per il computer, ma poco pratici ai fini della costruzione narrativa.
7) Saltburn, di Emerald Fennell
Saltburn è il secondo lungometraggio di Emerald Fennell, che realizza un’opera altamente provocatoria, interessandosi però più alla proposta di sequenze grottesche e ciniche, invece di riflettere sulla tesi della cattiva borghesia. Il colpo di scena artificioso, didascalico e perfettamente comprensibile anche senza uno “spiegone” interminabile, sembra essere uno specchietto per le allodole, un applauso che la regista si rivolge autonomamente mentre tenta di far sobbalzare lo spettatore dalla poltrona. Le lunghissime 2 ore vengono riempite da dialoghi poco funzionali, da una ricerca del sensazionale davvero esagerata e forzata, da scene provocatrici proprio in virtù di un effetto sorpresa. Saltburn è un prodotto fuori fuoco, dove le intenzioni vengono messe in secondo piano rispetto alla forma.
6) The Whale, di Darren Aronofsky
Citazioni letterarie, interpretazioni macchiettistiche e pedissequamente “lamentose”, una retorica profondamente ricattatoria e un’assenza quasi totale del linguaggio cinematografico. The Whale rientra tra i peggiori film d’autore del 2023, proprio perché cerca a tutti i costi di impietosire lo spettatore attraverso dei meccanismi costruiti ad hoc e mai sinceri, calando l’asso con la recitazione calcata di Brendan Fraser (scelto non a caso per il ruolo).
Come è solito fare Aronofsky, non mancano i suoi inutili rimandi alla religione, e in questo contesto come in altri, non se ne sentiva assolutamente il bisogno, anzi, il film ne esce ancor più sfilacciato e inconsistente. Oltre alla recitazione, i personaggi stessi sono bidimensionali e ridondanti nel proporre le loro idee di vita, nello sputare fuori sentenze, giudizi e sentimenti egoistici, finendo talvolta per contraddirsi nel giro di pochi minuti.
5) Empire of Light, di Sam Mendes
L’opera più personale di Sam Mendes, Empire of Light finisce ben presto nel dimenticatoio, poiché pretenziosa e artificiosa. Il cinema dovrebbe essere al centro di tutto, ma viene rilegato a scenografia e strumento non funzionale alla narrazione, che potrebbe tranquillamente farne a meno. Il fascio di luce viene citato nei dialoghi, ma la storia raccontata in malo modo è un ingenuo intreccio sentimentale contraddistinto da una forzata ossatura politicamente corretta. Forse, il regista è ancora scottato dall’Oscar perso nell’anno di Parasite, e ha provato a presentare all’Academy una formula costruita ad hoc per andare a premi; fortunatamente non ci è cascato nessuno.
4) Nuovo Olimpo, di Ferzan Ozpetek
Ferzan Ozpetek torna dietro la macchina da presa, ma persistono i problemi relativi al concepimento di un’opera. Il suo Nuovo Olimpo, disponibile in streaming su Netflix, è anacronistico quando non dovrebbe, smielato nei momenti clou, poco credibile nella maggior parte delle sequenze, anche per demeriti di un trucco da “mascheroni” di cui non se ne comprende il significato. La storia d’amore è immobile come la narrazione del film, farcita da inutili citazioni (meta)cinematografiche e da un senso del ritmo davvero inconsistente. Manca il pathos, non c’è alcuna dinamicità, e il finale è scopiazzato qua e là, nonché autoreferenziale.
3) The Palace, di Roman Polanski
Film fuori tempo massimo, in quanto strutturalmente concepito come un cinepanettone, il The Palace di Polanski è già vecchio. Le storielle sentimentali, i tradimenti, gli escrementi degli animali, i rapporti sessuali, sono pieni di connotati volgari e sparpagliati all’interno della storia senza una vera e propria idea narrativa. Gli schemini da cortometraggio vanno avanti per inerzia, e a crescere è soltanto un profondo imbarazzo per ciò che si vede in scena.
2) La quattordicesima domenica del tempo ordinario, di Pupi Avati
Fin dalle prime immagini in bianco e nero che accompagnano i titoli di testa del film, La quattordicesima domenica del tempo ordinario dichiara il suo intento: parlare di vecchiaia, attraverso un ripiegamento su stessi che annulla ogni possibilità altra. Il film di Pupi Avati prosegue, così, su tutta la linea, raccontando una storia che si presenta come estremamente vetusta e che si avvale di principi, tanto tecnici quanto narrativi, che non superano la prova del tempo.
Nello stesso periodo storico di numerosi testamenti artistici che volgono lo sguardo verso la modernità – come The Fabelmans o Il sol dell’avvenire -, La quattordicesima domenica del tempo ordinario compie un percorso completamente antitetico, rinchiudendosi in se stesso e affidandosi ad una componente tecnica assolutamente assente. La fotografia pessima, che lascia talvolta addirittura l’effetto del blue screen sullo sfondo, accompagnata ad un montaggio ancor più ridondante, definisce la cornice di un film che si arricchisce di interpretazioni orripilanti, tra cui quella di Lodo Guenzi nei panni del protagonista. Il vero problema del film è però la sua morale, che tende a normalizzare la gelosia perversa, la possessione della donna e l’amore tossico, in un periodo storico che dovrebbe, invece, procedere verso tutt’altro.
1) Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco, di Zack Snyder
Snyder ottiene piena libertà creativa dai produttori Netflix, e ci tiene a inserire ogni elemento che ama del cinema nel suo Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco. Come suggerisce il titolo, si tratta di una prima parte, in attesa (si fa per dire) della seconda. Il cineasta dopo aver divorziato dalla Warner Bros. DC, si è rifugiato nella piattaforma streaming di Netflix per potersi sfogare, ma il risultato è egoriferito, disastroso e del tutto vuoto. Alla faccia della libertà creativa, Zack Snyder qui spettacolarizza inutilmente la violenza e la porta all’eccesso, mostrando per circa 30 minuti un’invasione goffa e meccanica.
Come se non bastasse, il film è un anonimo agglomerato di elementi presi da lavori altrui: Star Wars, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, I sette samurai e persino il gioco Warhammer. Snyder si improvvisa anche direttore della fotografia, e la patina finta e abbondantemente digitalizzata rende le immagini talvolta opache, altre volte inutilmente color seppia. La scrittura dei personaggi è totalmente assente, poiché il regista ha esclusivamente ragionato per archetipi legati al mondo fantasy e allo sci-fi. Se questo è il risultato di una fantomatica autonomia, forse è meglio rivedere i piani. Qualche bella inquadratura può fungere da sfondo per il desktop, ma il tentativo di autocelebrarsi è così evidente che si perde il conto dei ralenti. Tra parentesi, questo effetto blurred sfumato, esattamente a che pro è inserito con così tanta abbondanza?