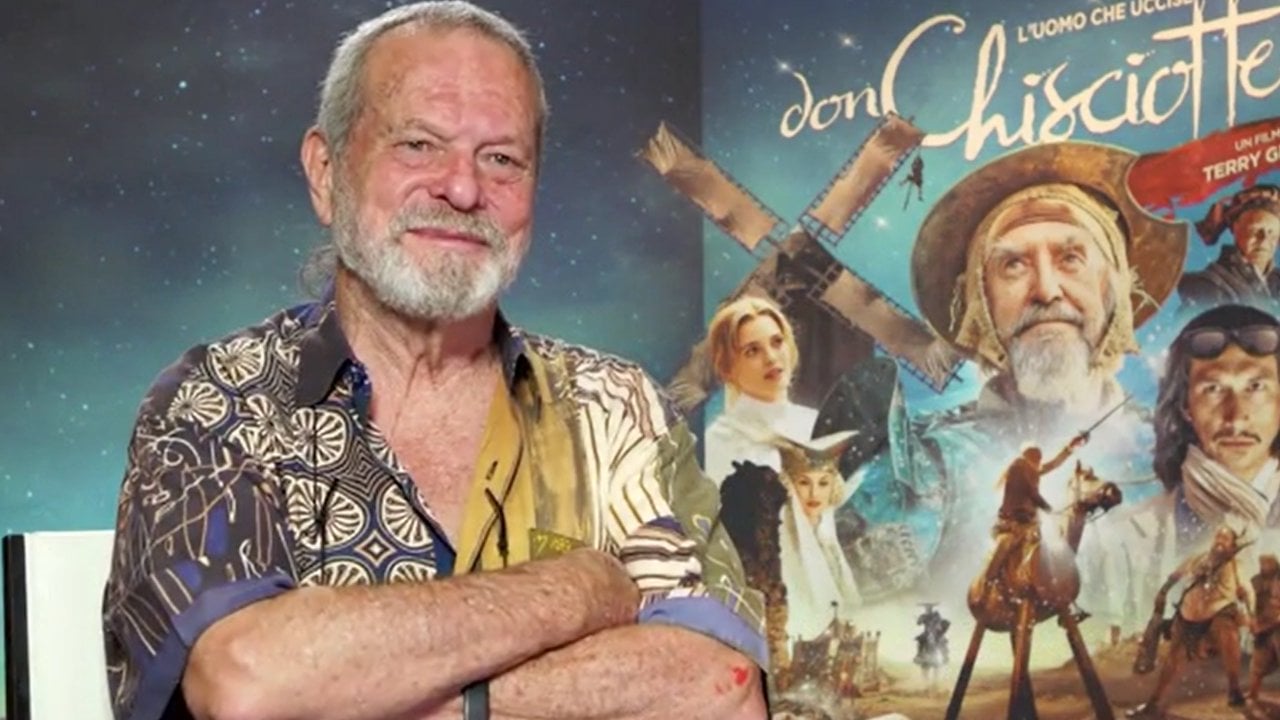Disponibile sulla piattaforma di Prime Video dall’8 giugno 2023, presentato fuori concorso alla 75ª edizione del Festival di Cannes il 20 maggio 2022 (dove ha ricevuto una standing ovation di sei minuti), “Tremila anni di attesa” è l’ultimo film prodotto, scritto e diretto dal premio Oscar George Miller. Un dramma sentimentale fantasy e fantasioso, che prova a scavare nei desideri più reconditi della natura umana. Ecco di seguito la recensione di “Tremila anni di attesa”, l’ultimo film di George Miller.

Tremila anni di attesa: la trama del film di George Miller
Studiosa di narratologia, Alithea Binnie è una donna forte ed indipendente che ha costruito la sua vita, consapevolmente e volontariamente, sulla solitudine. Niente marito, niente figli, niente genitori e a lei (forse) va bene così. A farle compagnia ci sono però occasionalmente le allucinazioni di esseri fantastici, spesso dall’aspetto demoniaco, dovuto principalmente dall’attaccamento alla sua materia d’insegnamento (scissa tra il mondo reale e le storie che racconta) e per un episodio accadutole nell’infanzia.
Un giorno Alithea deve recarsi ad Istanbul per una Convention, nella quale dovrà presentare assieme ai suoi colleghi il proprio lavoro. Immancabile il giro per il Bazar della città, dove la studiosa ritrova una particolare boccetta tra tante nel negozio, ma al quale il proprietario non sa dire la provenienza. Resasi conto che l’oggetto possa raccontare una storia (materiale sempre ben accetto per una narratologa), Alithea la porta con sé in hotel, solo per scoprire che si tratta della prigione di un Genio, il quale la stessa ha liberato. La creatura si offre di consueto di esaudire 3 desideri, ma Alithea è incapace di desiderare qualcosa dalla vita e si mostra diffidente nei confronti del Genio. Per renderla a suo agio allora, la creatura decide di raccontarle la sua storia e del perché abbia aspettato oltre 3000 anni per poter essere liberato da Alithea.
Tremila anni di attesa: il cantastorie e la divin creazione dell’Uomo
<<Mi chiamo Alithea. La mia storia è vera. Tuttavia, è più probabile che voi mi crediate se la racconto come una fiaba>>.
Basato sul racconto “Il genio nell’occhio d’usignolo” (The Djinn in the Nightingale’s Eye) di A. S. Byatt, l’ultima fatica del regista australiano George Miller – a 7 anni di distanza dal film spartiacque del decennio precedente “Mad Max: Fury Road” – è un dramma sentimentale fantasy e fantasioso, tanto nella sua realizzazione tecnica quanto nella sua audace volontà e bramosia di addentrarsi nelle profondità della natura umana, immutabile nel corso dei millenni. Il focus principale di “Tremila anni di attesa” (in originale “Three Thousand Years of Longing” che, forse più coerentemente, tende più ad indicare il desiderio, la bramosia) si basa quasi esclusivamente infatti su quello che, sempre più comunemente, viene definito storytelling, ovvero l’arte di narrare.
Insita nell’essere umano, la necessità di raccontare ed ascoltare storie ci accompagna fin dall’alba dei tempi, dove – in assenza dell’adeguata consapevolezza scientifica – ci si è sempre rifugiati nella narrazione (quanto più fantasiosamente convincente possibile) per dare un significato ed un senso alle inspiegabili manifestazioni della natura, specialmente alla morte e ad il senso della vita, per le quali l’Uomo si è dato da sempre risposta tramite la religione e la mitologia. Il cinema non fa sconti e l’obiettivo fondamentale per un regista sta proprio non solo nel raccontare una storia ma, soprattutto, far immergere l’ascoltatore ed il pubblico in quella narrazione. Lo sa bene ovviamente il navigato regista della saga di Mad Max, de “Le streghe di Eastwick” o del premio Oscar “Happy Feet”, che infatti continua a raccontare storie sul grande schermo (purtroppo sciaguratamente piccolo da noi) indipendentemente che si tratti di fantascienza, animazione, commedia ed addirittura horror, come quell’episodio “Terrore ad alta quota” del film “Ai confini della realtà” del 1983, con il quale “Tremila anni di attesa” sembrerebbe avere molto in comune. Soprattutto quando la storia è infatti completamente fittizia e fantasiosa, occorre comunque che sia tale da far credere allo spettatore che sia veritiera, o comunque convincente, per non far passare il narratore da abile cantastorie e scellerato giullare di corte.
Non abbiamo alcuna prova delle storie raccontate dal Genio nel film, con informazioni anche contraddittorie per la studiosa di narratologia, alle quali però Alithea crede perché, soprattutto, riesce ad empatizzare con la solitudine del narratore protagonista delle stesse. Un sentimento primordiale che il destino sfrutta per far avvicinare due personaggi solitari alla costante ricerca della libertà alla quale, tuttavia, non credono davvero. Nel vestirsi da cantastorie del Meddah turco (origini comunque greche per il regista australiano), George Miller racconta della natura cosmica dei personaggi tanto del Genio quanto di Alithea, quasi nata per raggiungere la pace, serenità e stabilità, per poi far accorgere al personaggio come l’altra faccia della medaglia sia quella dell’oblio, della solitudine. In quest’equazione Miller aggiunge una scheggia impazzita, quella dell’amore, del sentimento, che porta a cambiare le carte in tavola, mutando le proprie convinzioni e stravolgendo la propria vita. L’amore che spinge il Genio a voler rimanere intrappolato ed Alithea a rompere con la propria solitaria emancipazione, abbracciando il vero sentimento di un’altra persona. Raccontando di dei, eroi, re e palazzi d’oro, Miller rievoca semplicemente una storia d’amore che nasce tra le quattro mura di una camera d’hotel: la storia (intesa anche come storytelling) e l’amore che sono i pilastri, il fil rouge che lega il destino della razza umana nei secoli, nei millenni.
Una capacità e necessità, quella del saper estirpare l’essenza e il “fiato vitale” dalla narrazione, che tuttavia incontra da primo l’inevitabile scontro con la razionale ed oggettiva scienza (che si mostra anche concretamente come onde antagoniste alla vita del Genio) e, per secondo, delle pericolose derive che una certa narrazione possa condurre i propri ascoltatori. Senza scomodare lo “storytelling” (ad esempio antisemita) che ha fortemente influenzato il secolo precedente, Miller si prende qualche minuto per additare il bigottismo e l’ipocrisia socio-culturale frutto della Brexit ma, in generale, di politiche isolazioniste ed autoritative. Da isola forte ed indipendente, Alithea si rende invece conto di volere in realtà l’amore e la vicinanza di qualcuno e decide di esprimere il suo desiderio, quello che le donne vogliono davvero. Poco importa poi se ciò è poi solo frutto della sua accademica immaginazione, con Miller che lascia volontariamente il dubbio allo spettatore: una storia vera è quella alla quale si vorrà credere.

Tremila anni di attesa: fino a che punto si crede alla storia narrata da George Miller?
<<Mi piace. Non so cos’è, ma la sua storia dev’essere affascinante>>.
Arrivati a questo punto diventa quindi obbligatorio chiedere quanto lo spettatore possa credere alla storia narrata dal regista George Miller. Sicuramente i protagonisti di “Tremila anni di attesa” ci credono ma, fuori dallo schermo, la certezza inizia a scemare. A 77 anni, uno degli esponenti di spicco del nuovo cinema fantastico (fin dal suo “Interceptor” del 1979), si mostra divin creatore di un lungometraggio di “portata epica” (come dichiarato dallo stesso Miller), forse fin troppo. Sebbene la sceneggiatura, scritta a 4 mani anche con Augusta Gore, sia comunque intrigante e sapientemente inquadrata (riferendosi qui unicamente all’aspetto narrativo, per quello visivo si arriverà tra poco), innegabile infatti come il soggetto di partenza perda di chissà quale originalità (comunque elemento fondamentale per un fantasy) e come la scrittura tematico-narrativa tenda troppo spesso a ripetersi per risultare (senza esserlo del tutto) inconcludente o capace di portare efficacemente a termine il percorso che ha mosso i primi passi in quella camera d’hotel. La love-story non convince emotivamente (decidendo invece di prediligere un approccio più intimista dei singoli personaggi), lo scontro ideologico dal potenziale vincente che vedrebbe la storica tradizione nel raccontare storie e la perdita di magia/creatività frutto della necessaria oggettività scientifica moderna è solo abbozzato, la critica politica ridotta a gag.
Una sceneggiatura, dunque, che dal materiale a propria disposizione risulta così davvero poco incisiva, per un approccio psicoanalitico sicuramente mai banale e “sbagliato”, ma comunque incapace di reggere la spericolata messa in scena. Già, perché ovviamente la sceneggiatura non fonda unicamente le basi di dialoghi, temi e caratterizzazione dei personaggi, ma si concentra anche di descrivere il “cosa” nel processo di realizzazione della pellicola. Molti sono infatti i guizzi fantastici e fantasiosi architettati dal regista, coadiuvati da una forte consapevolezza tecnica dietro la macchina da presa da grande conoscitore del mezzo cinematografico come è Miller. Ed è così che il montaggio di epiche e magiche illustrazioni, in piano-sequenza o in fluide dissolvenze, caratterizza una messa in scena di alta spettacolarità, che pone al centro una ricostruzione dell’immagine di alto profilo ed uno spasmodico utilizzo della CGI.
Sotto il primo aspetto, “Tremila anni di attesa” gode dell’epica fotografia di John Seale che, oltre ai lavori in “L’attimo fuggente” e “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, infonde una visione satura e particolarmente vivida nelle sue tinte doratamente calde, riportando una lucentezza solare al pari polverosa e tenebrosa di “Prince of Persia – Le sabbie del tempo” e, soprattutto, di “Mad Max: Fury Road”. Un ruolo altrettanto fondamentale, nell’undicesimo lungometraggio di George Miller, lo giocano anche la ricostruzione scenografica e costumistica degli aneddoti narrativi rievocati dai protagonisti, che permette uno slancio non indifferente nell’immersione delle “sabbie del tempo” mantenendo intatto il convincente carattere di veridicità, fondamentale (per quanto visto) per trainare l’aspetto narrativo. Sebbene la messa in scena di “Tremila anni di attesa” sia indubbiamente di alto profilo e rispecchi appieno l’atmosfera fantasy, tale certezza non può essere mossa anche dal punto di vista dell’effettistica (che, addentrandosi audacemente in metafore di profonda sovralettura, potrebbe anche essere uno dei fattori incarnanti lo scontro vecchio-nuovo, racconto-scienza/tecnologia sopracitato). Miller si addentra infatti in un film di portata epica anche per quanto riguarda soprattutto la CGI che, in alcuni frangenti si mostra effettivamente di alto livello mentre, in più di un’occasione, perde completamente la bussola, finendo per risultare alla stregua di un filtro Instagram scaduto da qualche anno. Se è comunque (quasi) sempre vero che gli effetti speciali andrebbero presi con le pinze quando ci si addentra nel campo fantasy (cosa vuol dire che un effetto speciale è “veritiero” se si parla di un elemento fantastico? Dove viene dogmatizzato che un flusso magico non può ad esempio essere pixelato?), è altrettanto vero che lo stacco qualitativo tra un effetto e l’altro colpisce inevitabilmente in negativo, facendo perdere la caratteristica primaria della sua convincente realizzazione.
Ultimo, ma non per importanza, elemento base di “Tremila anni di attesa” non poteva che essere quello dell’interpretazione recitativa dei protagonisti, sui quali si regge questo racconto epicamente intimista. Anche qui si denota infatti la schizofrenia artistica del film di George Miller. L’attrice britannica Tilda Swinton non ha certamente bisogno di ulteriori prove sul grande schermo per rendere nota la sua altissima capacità di rubare quasi completamente la scena, forte di un’incisività caricaturale e nella creazione psicologica del proprio personaggio che, oggigiorno, registra poche rivali, soprattutto nel cinema di genere. Sebbene però la Swinton riesca abilmente anche qui a dare sfoggio della propria bravura, anche nel cambiare non solo espressività ma anche consapevolezza del proprio personaggio, in “Tremila anni di attesa” manca effettivamente quel graffio emotivo decisivo per lasciare una profonda incisività ad un racconto che, comunque, si basa anche e soprattutto sui sentimenti e sul romanticismo dei suoi interpreti. Non corre sicuramente in suo aiuto il collega Idris Elba, Genio d’ebano tanto possente quanto fragile che, tuttavia, non riesce mai ad allontanarsi da un’espressività monocorde e fin troppo piatta, soprattutto negli aneddoti dove, al contrario, sarebbe stato fortemente necessario (non è umano e non dovrebbe provare sentimenti in tal senso, ma dal punto di vista filmico convince appunto a metà).
Insomma un film, quello dell’ultima fatica dell’acclamato regista George Miller, che gode di un’alta spettacolarizzazione e fantasiosa realizzazione per trainare un epico racconto di sentimenti, incarnando la necessità e la dedizione del ruolo del cantastorie nel raccontare la fiaba di un amore mitologico e millenario. Un prodotto da tenere in considerazione, ma non esente da fin troppe note stonate che lasciano, per “Tremila anni di attesa”, l’amaro in bocca e la convinzione di un materiale potenzialmente incisivo ma, purtroppo, bruscamente sprecato al termine della ballata del bardo.