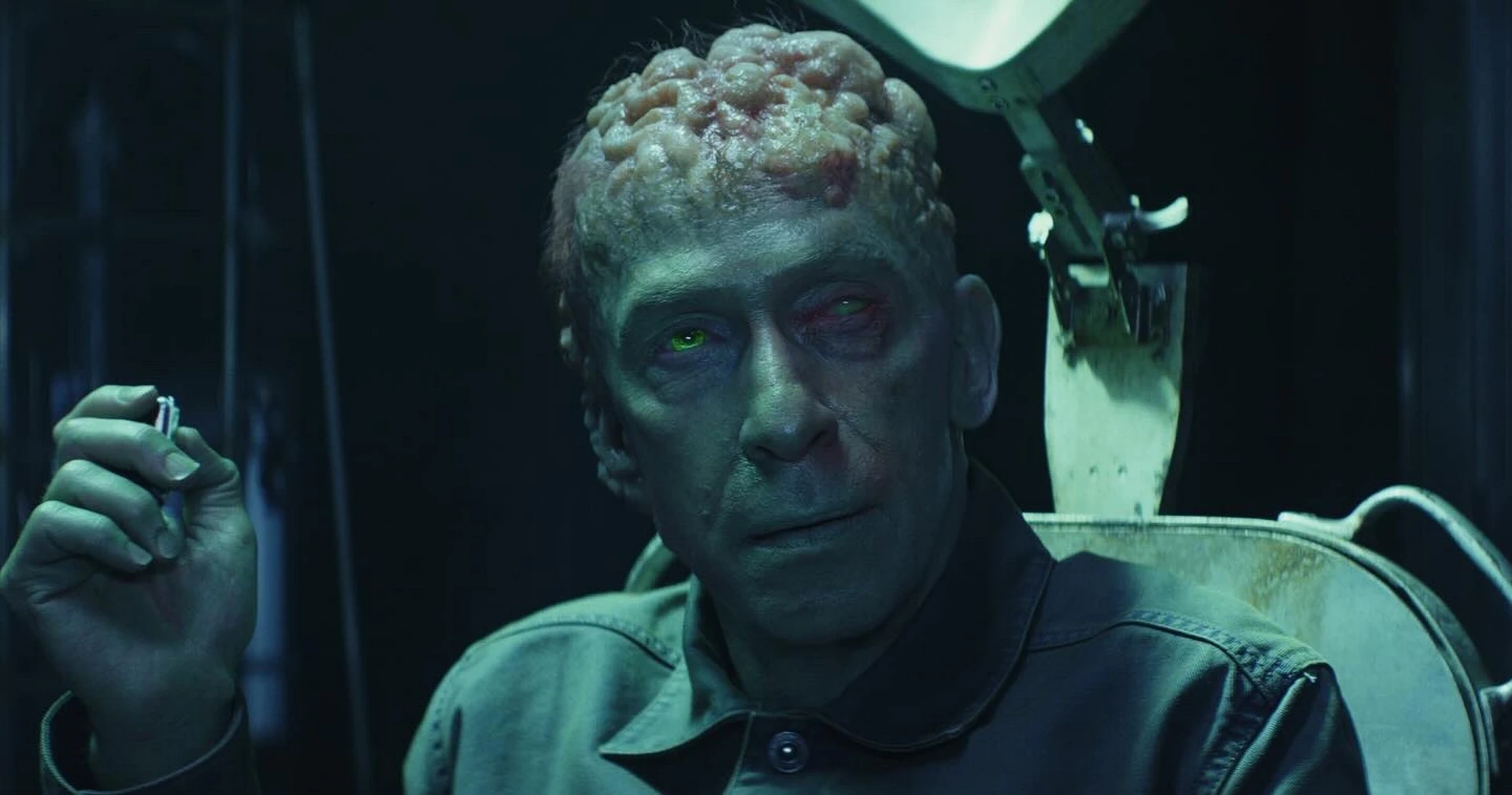Articolo pubblicato il 27 Ottobre 2024 da Bruno Santini
Parthenope di Paolo Sorrentino è un film che ha fatto discutere tantissimo in virtù di numerosi elementi, che hanno interessato il lungometraggio e soprattutto il suo rapporto con lo spettatore. Il film, infatti, riflette su una serie di temi che sono stati portati sullo schermo grazie ad alcune interpretazioni – su tutte quella di Celeste Dalla Porta – e che hanno garantito quel risultato che si osserva. Naturalmente, sono tante le domande che un film del genere lascia e, tra tutte, si ragiona soprattutto a proposito del significato e della spiegazione del finale di Parthenope. Ma come finisce il film di Paolo Sorrentino? Nel comprenderlo, è importante sottolineare quale sia il significato della scena finale del film.
Come finisce Parthenope di Paolo Sorrentino: il significato della scena finale del film
Per comprendere quale sia la spiegazione del finale di Parthenope di Paolo Sorrentino, è molto importante sottolineare innanzitutto come finisce il film e quale sia il significato della scena finale. Come osservato all’interno del film, a seguito del suo costante viaggio, Parthenope giunge a Trento per diventare una docente universitaria, potenzialmente in sostituzione del suo professore Devoto Marotta.
La rappresentazione di Parthenope adulta è importante, soprattutto perché – a distanza di 40 anni dalla rappresentazione degli anni ’70 che viene offerta nel film – la donna può rispondere a quella domanda che viene spesso posta nel film: a che costa stai pensando? La risposta appare chiara ed è il motivo su cui regge tutto il film, e che permette allo stesso Sorrentino di ragionare proprio come un archeologo: come spiega Marotta alla sua studentessa, prima che lei parta, “l’archeologia è vedere”. Un qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo una conquista che arriva soltanto alla fine della vita, quando ci si spoglia di futili emozioni, desideri e pensieri di cui si è pieni durante la giovinezza: soltanto da adulta, allora, Parthenope potrà capire e vedere ciò che aveva soltanto guardato per tutta la vita.
La spiegazione del finale di Parthenope di Paolo Sorrentino
Avendo sottolineato quale sia il significato delle scene finali del film, è possibile procedere con la spiegazione del finale di Parthenope di Paolo Sorrentino. Come è stato possibile osservare, il film in questione riflette su una serie di temi che sono legati alla gioventù e, soprattutto, al sentimento che deriva da questa; per questo motivo, riflettere a proposito del passato e di quelle scelte che sono state compiute durante la giovinezza, da parte della Parthenope adulta, è un modo anche per riqualificare se stessa e il suo rapporto con la realtà napoletana. Un po’ come Greta Cool, in effetti, Parthenope era stata molto critica nei confronti della città di Napoli e del popolo napoletano, ritenendolo caotico e imperfetto e decidendo di vivere a Trento per 40 anni, nonostante potesse tornare a insegnare archeologia al Sud in sostituzione del suo professore, Devoto Marotta.
Quando, tornando finalmente a Napoli, osserva i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, capisce: c’è da dire che la bellezza di un popolo esultante era stata già raccontata da Paolo Sorrentino in È stata la mano di Dio, e che la figura di Maradona era stata citata dallo stesso Sorrentino agli Oscar, accanto ai Talking Heads e a Fellini, nel suo discorso di ringraziamento per la statuetta ottenuta. Ancora una volta Napoli, i napoletani e la profonda radice culturale – questa volta legata al calcio – rappresentano un motivo di genuinità, di sincerità che viene ritrovata da quella Parthenope ormai adulta che, ritornando a Napoli, può finalmente tirare un sospiro di sollievo osservando tutto ciò a cui ha rinunciato per 40 anni. Nel suo sguardo non c’è più critica ma ammirazione, alla maniera di quel “Napul è” di Pino Daniele (non a caso canzone finale di È stata la mano di Dio) che, dopo aver elencato tutti i difetti della città, ne elogia la sua magica e irrinunciabile bellezza.